E’ strano come da un bivio possano dipanarsi strade tanto diverse. Come dallo stesso cuneo, dalla stessa origine, possano generarsi percorsi così divergenti. Come se l’asfalto ad un tratto si fosse alzato e diventato cielo.
Questo pensava Mameli. Con la testa tra le nuvole. In silenzio. In mezzo all’incrocio. Davanti al corpo. Non aveva nulla in mano se non un indizio: una sciarpa gialla da aviatore.
La parola italiana “sciarpa” deriva dal francese echarpe. Grazie alla sua conoscenza delle lingue aveva dunque raccattato in pochi attimi sulla scena del crimine un indizio e una definizione: meglio di pochi secondi prima – quando aveva solo una morta – ma niente di che per iniziare una indagine con la certezza di concluderla con successo.
Non sapeva perchè, ma sentiva però che qualcosa con la Francia quel delitto avrebbe avuto a che fare, i francesi notoriamente la sanno lunga. Come c’entrava qualcosa Barcellona, la città dove viveva da due anni.
Mameli sceglieva da tempo le sue mete girovaghe in base al colore degli aeroporti. Vi spiego.
Firenze era un aeroporto color erba: un aeroporto verde. Malpensa – Terminal 2 – è un aeroporto arancione, intriso come è in ogni dove di insegne Easy Jet. Tra questi due poli, uno romantico e uno pragmatico, c’è stata una gran confusione.
Per tanti anni a Mameli risultò difficile una così netta immagine di colore associata ad un aeroporto, forse perché nei maggiori scali vi è una multiforme presenza di compagnie aeree, di loghi e code colorate. Ma quella sensazione, che si era attutita col passare del tempo, gli tornò immediatamente alla mente una volta atterrato qui, alle porte del Mediterraneo.
Barcelona “El Prat de Llobregat”: l’aeroporto giallo.
Avete presente gli aerei della Vueling? Giallo ovunque. Barcellona è il loro hub e la fanno veramente da padrone.
In questo aeroporto transitano ogni giorno, e molti con funzioni di feederaggio, alcune centinaia dei 1.000 voli giornalieri della compagnia che, l’anno passato, ha trasportato più di 114 milioni di passeggeri.
104 sono i velivoli della famiglia Airbus, e per non fare “ingiustizie”, 105 quelli della Boeing. Interessante è vedere la composizione della flotta: dieci sono gli A-330 (più 8 in ordine e tre cargo), altri tre cargo sono A-310, sette invece gli A-340, trentasei A-321, ventotto A-320, e quattordici A-319. Dalla Boeing invece arrivano dodici B-777 e novantatre B-737, dei quali dieci ER, sessantasei -800, quattordici -700 e tre -400.
Potete quindi capire perché l’aeroporto potesse a Mameli sembrare giallo.
C’era un solo uomo in città famoso per indossare sciarpe gialle da aviatore: era Gonzalo Alverà, detto Mister Boqueria, lo chef più amato e apprezzato in Spagna e nel mondo per la sua cucina elastica.
Mameli trasse le sue informazioni sul tema da un giornale locale dove veniva ripreso uno stralcio di intervista: “L’unico strumento certo del mio lavoro è l’immaginazione di volare. La mia cucina condensa accumulazione del passato e vertigine del vuoto, compresenza continua d’ironia e angoscia: insomma una fusione in cui il perseguimento d’un progetto strutturale e l’imponderabile senza gravità diventano una cosa sola”.
Il soprannome di Mister Boqueria gli derivava dalla leggenda secondo cui ogni giorno reinventava il menù del suo ristorante dopo aver percorso in lungo e in largo lo splendido mercato a metà della Rambla.
Questa cosa della cucina volante a Mameli proprio non andava giù. Non la capiva. Gli sembrava una cosa troppo intellettuale, per palati fini, per bocche non italiane.
E poi tutta questa meditazione sul cucinare lo sfiancava: lui che non sapeva resistere, che quando gli veniva il trip di cucinare doveva farlo nel primo posto dove trovava un fornello. Lui che quando aveva fame doveva mangiare. E basta. Senza fronzoli.
Da buon italiano, Mameli amava la cucina semplice e genuina.
Col lavoro che faceva gli risultava difficile mangiare bene e quindi quando poteva, riuscendo a sganciarsi prima alla sera da una indagine o da un sopraluogo, amava mettere le gambe sotto ad un tavolo e cenare a rotazione nelle diverse trattorie italiane di Barcellona: al Made in Italy, alle Tre Venezie, al Mercante, al Cucina. Ogni tanto inframmezzava una pizza da Gusto.
Niente di particolare, se non che da qualche tempo, a ventiquattrore di distanza esatte dal momento in cui si gustava l’ultimo boccone tricolore, nello stesso posto in cui aveva mangiato, la polizia avrebbe trovato una donna morta.
Con la bocca piena di spaghetti e bendata da una sciarpa gialla da aviatore. Le ragazze erano tutte spagnole, cosa quantomeno bizzarra in una città che pullula di belle ragazze da tutto il mondo.
Se dopo il primo omicidio pensò al caso, al secondo alle coincidenze, al terzo alla sfortuna, al quarto delitto Mameli fu costretto a porsi delle domande, e non semplicemente a darsi risposte ovvie e inutili. Tanto più che il suo superiore, l’ispettore capo Grancan, voleva qualcosa di più concreto di semplici menzogne contraffatte spacciate per ipotesi investigative.
A Mameli questo concetto che un detective dovesse portare dei fatti e non delle argomentazioni non era mai andato a genio. Per lui gli indizi erano fatti di materia setosa. Come le nuvole.
Qualche volta aveva pensato che sarebbe stato perfetto nel suo ruolo al tempo dei Greci. Nel diritto antico il crimine, anche l’omicidio, non è pensato come una minaccia contro la società, che infatti non lo persegue d’ufficio: dunque il detective non agisce in nome della società o della verità, ma su iniziativa, e spesso per un interesse, personale. In questo senso, Mameli sarebbe stato un ottimo detective assente, un formidabile investigatore potenziale. Un imbattibile detective giallo, colore che nell’antica Grecia rimandava proverbialmente alla stupidità e alla follia. Secondo Grancan, invece, il detective era colui che assume su di sé un compito che sarebbe proprio di tutta la società: quello, cioè, di rappresentare la richiesta di giustizia della vittima, che è impossibilitata ad agire di persona in quanto il delitto l’ha soppressa.
Grancan era invasato dei libri di Chandler e voleva un poliziotto. Di un qualunque colore possibile, magari senza onore, ma che fosse un poliziotto. Certo.
Obbligato dal suo capo decise dunque di dare inizio all’indagine leggendo il rotocalco e interessandosi di Mister Boqueria. Il passo successivo fu fare un salto al regno della cucina volante.
Il ristorante era un vecchio hangar poco lontano dalla Rambla completamente ristrutturato; un palazzo di cui era stata sventrata la facciata in modo che, dal pianterreno alle soffitte, tutte le stanze che sulla parte anteriore dell’edificio fossero immediatamente e simultaneamente visibili.
Dai grandi oblò si mostravano quindi la cucina, il magazzino delle cibarie, la stanza dell’occhio (dove il vate seguiva personalmente l’estetica di ogni piatto nella sua presentazione finale), e le zone dei tavoli, distribuiti su tre piani con quello più in alto adornato a mò di suite culinaria.
Data la sua proverbiale pigrizia Mameli non prenotò.
Appena varcata la porta, gli parve di essere piombato al Camp Nou prima della mitica sfida col Real Madrid, tanta era la gente che attendeva il proprio turno.
Non presentandosi per quello che era – uno sbirro improbabile – gli venne regalata una anticamera di un’ora, sul modello della coda al controllo passaporti all’aeroporto di Tel Aviv. C’è da dire che, se si fosse dichiarato, probabilmente l’avrebbero cacciato in malo modo.
Comunque era martedi, il giorno del menù giallo; decise di ingannare l’attesa riflettendo tra sé e sé sui vari significati del colore. Gli sarebbe sicuramente servito.
Quando si sedette – tavolo rigorosamente da uno – gli presentarono nell’ordine: un timballino di cueso affumicato in salsa di zafferano; un merluzzo marinato protetto in una carlinga di peperone giallo; dei mini trolley di pollo annegati in una julienne di cipolle aromatizzata alla curcuma; e per finire uno zabaione caldo profumato al limone.
Non poté scegliere. Il menù era imposto.
Avrebbe voluto uscire pensando con leggerezza orientale che il giallo era il colore del sole, della fertilità, della regalità … invece aveva mangiato poco, e aveva ancora fame, per cui la sua mente italica si accese su una immagine da immediato dopoguerra, in cui il giallo era la tinta di alcune malattie quali l’itterizia, le manifestazioni d’avvelenamento o le nausee.
Avrebbe dovuto scoprire qualcosa di più. Qualcosa di significativo. Se non altro perchè non avrebbe sopportato un altro pranzo più inutile e avvilente.
Mister Boqueria cominciava dunque a stargli veramente antipatico: la cucina in volo perenne – invece che un sottile miracolo di equilibrio – gli sembrava un modo per riprendersi il sapore indietro prima che l’avventore avesse la soddisfazione di gustarlo. Insomma: una arte disonesta.
Se avesse avuto solo un po’ di coraggio – e di orgoglio nazionalistico – quello che avrebbe dovuto fare sarebbe stato sabotare il ristorante esponendo all’esterno una bandiera gialla d’avvertimento per i malcapitati adepti dello chef, come si faceva nelle città dove era scoppiata una epidemia o sulle navi che avevano a bordo gli appestati. Oppure avrebbe dovuto prendere a prestito la segnaletica gialla delle piste di atterraggio, per indicare al popolo ignaro, di non andare a quel ristorante.
Ingrugnito dal languore, decise che il modo migliore per pensare al da farsi sarebbe stato una bella passeggiata di metà pomeriggio sul lungomare che porta a Barceloneta.
Al limite, se proprio non gli fosse venuta nessuna idea, poteva almeno ritemprarsi gli occhi sbirciando qualche schiena femminile intenta a fare jogging. Era inizio aprile, una stagione magnifica a quelle latitudini: temperatura incerta tra venti e venticinque gradi, brezza delicata in viso. Il sole era talmente bello e forte che pareva in grado di sfumare di giallo tutto il cielo: la sua illuminazione radiante, il suo uscire da una sorgente centrale per sfaldarsi in tutte le direzioni, spostandosi dal centro verso l’esterno, disegnava un impulso centrifugo di apertura, liberazione e fuga.
Un senso di estroversione, un aspetto gioioso e vivace, sereno e leggero, che Mameli invidiava tantissimo.
Mentre era davanti al Mare Nostrum, guardando la statua di Cristofolo Colombo pensò che, nonostante il fastidio comportatogli dalla sola idea, era necessario fare un’altra visita a Mister Boqueria: stavolta non per assaggiare i suoi furti culinari, ma per fargli le fatidiche domande che aveva imparato dai film americani un vero detective non può derogare.
Si preparò al colloquio di tutto punto, stavolta: indossò il suo completo migliore, estrasse dall’armadio delle scarpe italiane di marca (una delle poche prove rimaste del fatto che anche lui avesse avuto anni fa un matrimonio) e – come fanno i guerrieri Masai – dipinse il suo corpo e il suo distintivo di giallo ocra per prepararsi alla battaglia. Lo fece con un pennarello delebile.
Dopo una breve indecisione, e molte prove davanti allo specchio, optò alla fine per non indossare un gilet da apemaia copiato da alcune tribù degli Indiani d’America, che con questo stratagemma ritengono di poter ipnotizzare il nemico.
Forse un avvertimento sul fatto che anche lui, come le vespe, nascondeva sotto la buccia un pericoloso veleno non sarebbe stato del tutto inopportuno, visto il risultato dell’interrogatorio.
Il profeta della cucina per finta si presentò attorniato da tre servi sciocchi: una addetta stampa vestita da hostess ma col canino in evidenza, cinquantenne ex franchista con evidente sindrome da menopausa aggressiva; uno steward del marketing, con troppo gel e troppi capelli per non risultare antipatico; e un guru spirituale con saio damascato e sandali post francescani, una sorta di Demis Roussos senza la precedente gloriosa carriera negli Aphrodite’s Childs tale da giustificarne la presenza in scena.
Vi risparmio i dettagli. In definitiva, il succo è che Mister Boqueria, affossato coi suoi 140kg in una poltrona da sovrano tipo Diamond Luxury First Class di Etihad, non mi disse nulla, se non chiedermi se mi era piaciuto il pranzo di due giorni prima, e a seguire pontificare la superiorità della sua cucina su quella italiana, capace secondo lui solo di rienventare sino alla noia la stessa pastasciutta, lo stesso spaghetto al pomodoro.
Ah dimenticavo: c’era pure l’avvocato – un principe del foro catalano conosciuto soprattutto come famoso puttaniere ma con amicizie molto in alto – che dopo la mia prima domanda mi bloccò violentemente ogni possibilità di procedere citando a caso articoli del codice civile, penale e aereonautico che non conoscevo, ma che sembravano perfetti a salvaguardare il suo assistito da ogni accusa anche solo velata o pensata.
Uscii se possibile più incarognito di quando ero entrato, quasi che il pennarello mi avessse creato istantaneamente una allergia diffusa tale da costringermi a grattarmi ovunque.
Decisi di annegare la tristezza e la rabbia sparandomi un pane&tomato alla prima taperia dietro l’angolo, con un piattino di jamon serrano e un bicchiere proletario di Torres. Non mancai di sporcarmi la camicia, mi succedeva sempre quando ero nervoso, oppure quando facevo le cose soprapensiero o in trance musicale.
Amavo Paolo Conte alla follia, la sua musica mi permetteva di sentirmi italiano e internazionale allo stesso tempo. Un italiano vero. Umile ma eccellente.
Legato a poche parole bofonchiate ma capaci di tradurre attimi, donne, immagini, palpiti.
Quando lo ascoltavo deambulavo saltando per la casa come un bambino, e alcune mie compagne casuali mi hanno confessato che lo cantavo pure di notte nel sonno e a volte mi alzavo sonnambulando e facendo cose che non avrebbero potuto descrivere nè ricordare. Mi faceva sentire meno straniero, nella appartenenza e nel linguaggio: io che non parlavo ancora bene il catalano dopo due anni di Barcelona.
A volte mi sembrava addirittura di non possedere un corpo, o perlomeno di una sembianza fisica codificabile dai catalani come tale: mi sembravo fatto di solo pensiero e nuvole. Ma allora: perché avrei dovuto combattere il crimine per una società che non mi aveva dato mai vera cittadinanza? Per un capo che odiava il mio modo di esprimermi, i miei borbottii da balbuziente ai limiti della crisi del linguaggio?
Il problema era capirsi. Non mi capiva Barcelona. Non mi capiva Grancan. Non mi capiva Mister Boqueria. Non mi capivano le donne.
Così, senza contatti sociali se non quelli creati dai miracoli della musica nella mia testa, regredivo praticamente all’età della pietra. Dialogavo solo con gli uccelli, e peraltro anch’essi molte volte non mi rispondevano, frustrando l’amore che ad essi rovesciavo addosso.
Da qualunque parte guardassi, mi trovavo immerso in una costante idea di incertezza, nell’intestino turbolento di un sistema instabile nel quale il mio minimo errore si amplificava.
Questa indagine, nella sua natura inafferrabile, riaffermava l’impossibilità di confinare il mondo – e ciò che in esso accade – entro i limiti della conoscenza umana.
Era tutto troppo ingarbugliato, non poteva esistere un metodo: se non quello di interrogare gli alieni col telescopio e chiedere loro consiglio. Dallo spazio, direttamente dalla loro astronave, mi restituirono prontamente la risposta che mi serviva. Molto terrena: pagai un testimone che incastrò Mister Boqueria. Lo fece sbattere in prigione e il giorno dopo i giornali erano pieni della notizia strillata in prima pagina. Rimase in carcere tre mesi, nel corso dei quali dimagrì 45 chili.
Nel frattempo – a dimostrazione che il mondo degli chef è un mondo di squali – i messaggi di delazione si erano moltiplicati e quindi Alverà, incarcerato senza alcun motivo e solo grazie ad architetture tipiche della retorica aristotelica o dei kamikaze giapponesi più che dell’investigazione moderna, piano piano stava diventando il perfetto colpevole.
Decisi di festeggiare la vittoria tornando trionfalmente al mio ristorante italiano preferito. Era tanto che non lo facevo, se non ricordo male dall’ultimo omicidio. Fu una serata memorabile, alla fine estasiato dalla sensazione di essere riuscito nella mia impresa arrivai addirittura a brindare con me stesso.
Senonchè ci fu un nuovo delitto. Inatteso. Ventiquattr’ore dopo.
Alverà fu scarcerato immediatamente grazie alla sagacia violenta del suo avvocato (e per amor di giustizia ed etica santiddio): era un uomo nuovo. Dimagrito, sobriamente elegante, innamorato della vita e di una nuova donna (una secondina con l’hobby della poesia) che aveva conosciuto in carcere. Mi scrisse pure una lettera di ringraziamento, che era dolce e priva di acrimonia.
Non avrei voluto essere Mameli quel giorno davanti a quella lettera. E non vorrei essere stato Mameli quel giorno davanti a Grancan: invece lo ero, e mi spaccò la faccia di insulti. Dovevo farmi venire un’idea. Dovevo escogitare un piano di volo per uscire dalla turbolenza dove mi aveva ben relegato la realtà dei fatti.
Mi serviva il giallo come una sorta di lampadina che si accende, un insight, una presa di coscienza finalmente chiarificatrice. Mi convinsi che il colpevole doveva per forza provenire da quella stanza dove avevo incontrato Alverà.
Andai per esclusione: il guru non poteva essere: troppo laido e ben pagato per le sue conoscenze esoteriche per sporcarsi le mani nei vicoli del barrio a ficcare spaghetti in gola alle donne. Al limite poteva servirmi se avessi deciso di farmi aprire il chakra giallo, corrispondente al plesso solare e alle funzioni legate all’attività dell’intelletto. Ma non mi conveniva capire troppo.
Meglio puntare sugli altri due e decisi di torchiare per primo quello più debole: lo steward con troppo gel e troppi capelli. Per compiacere Grancan, da buon marlove dei poveri lo feci sequestrare mentre era in sauna e lo feci tradurre nel mio squallido ufficio vicino a Santa Maria del Pì. Mi preparai sul retro di un sacchetto per il vomito di Air France la frase di benvenuto: “questa lampada che ti pianto in faccia può illuminare o accecare, riscaldare o bruciare; può essere annuncio di decadenza e dell’approssimarsi della morte, il colore dell’Ovest e del declino”.
Ero verde di cattiveria. Avevo le tonalità luride dello zolfo e della bile. Ero diventato il polo negativo del giallo: aspro, pungente, acido. Ma lo zolfo è un minerale che brucia senza fiamma, una falsa fiamma dunque. E anch’io alla fine mi accorsi di far paura solo a me stesso.
Il malcapitato mantenne invece – nonostante lo shock – una certa buona educazione, e con ottima sintassi – gesticolando come ad indicare le uscite di sicurezza – mi confermò la sua innocenza e il suo alibi di ferro per tutti gli omicidi. Era sempre da qualche parte in compagnia di qualcuno che avrebbe potuto testimoniare a suo favore.
Passai allora con decisione a spremere la addetta stampa pseudo gestapo. Con lei cambiai strategia, decisi di sorprenderla a casa dove magari avrei potuto pizzicarla nel bel mezzo di un gioco erotico sadomaso. Era così, avevo fatto centro.
Sfondando la porta come avrebbe fatto Robert Mitchum mi trovai nel bel mezzo di un sabba impazzito: lei vestita di lattice nero e appesa con anelli medievali ad una trave del soffitto, veniva frustata da un giovane pilota barbuto e capellone ancora in divisa.
Lei era ciò che di peggio poteva esistere: falsa, carica di invidia e rancore. E aveva un chiaro movente: ex starlette del cinema vicino alla dittatura, aveva dovuto subire un rapido e lacerante oblio per non essere imprigionata all’arrivo della democrazia.
Si era reciclata, cambiando identità e look, nel mondo delle agenzie di comunicazione e delle pr giungendo poi al dorato esilio di Mister Boqueria. Inoltre, come aggravante decisiva, da giovane aveva avuto esperienze di spettacolo nel tradizionale Teatro di Pechino, dove il trucco giallo degli attori indica la crudeltà, la dissimulazione ed il cinismo.
Era perfetta come colpevole. Ideale anche per la società che in quel modo avrebbe finalmente sconfitto non solo una pericolosa pervertita, ma anche lo spettro della dittatura franchista di cui era stata la pin up più odiata.
Era malata della sua trasgressione, non poteva farne a meno, nemmeno per una sola sera … e questo la salvò. Infatti a suo discarico snocciolò la lista dei suoi persecutori – tutti piloti giovani, capelloni e anarchici appartenenti a varie compagnie di bandiera – da cui si faceva picchiare, a volte in orge di gruppo.
Ogni dannata notte, un festino con annesso gatto a nove code ratificava un diverso check-in fetish e quindi la sua assoluzione.
Cazzo, pensò Mameli, possibile che tutti sono sempre con qualcuno quando avvengono i delitti? Possibile che l’unico ad essere solo e senza alibi sono io? Se il giallo è il colore dell’olfatto, cominciava seriamente a sentire puzza di sconfitta.
Ne ebbe ancor di più la certezza dopo i miliardi di calci in culo che gli dedicò amorevolmente Grancan alzandolo letteralmente dal suolo.
L’ispettore capo, pur ascoltando i racconti di Mameli, pur amando il modo col quale aveva compiuto gli interrogatori e sfondato le porte, ormai non credeva più alle sue parole, o meglio ai suoi mugugni. Che assomigliavano sempre più alle comunicazioni sbrecciate di una scatola nera.
Persino i fonemi elementari in catalano scarso li catalogava automaticamente come pura invenzione.
C’erano stati cinque delitti. Tutti uguali. E non c’era lo straccio di una prova per arrivare al colpevole. Ma se decollare è facoltativo, atterrare è obbligatorio: non solo per un pilota, anche per un detective.
Evidentemente, ormai era chiaro che Mameli viveva nel suo mondo e non riusciva a far partecipare nessun altro dei suoi pensieri. Quando ci provava, i risultati erano quantomeno disastrosi. Con Grancan terrificanti. Decise allora che era meglio tagliare la corda: meglio un’altra città, altre persone, altre solitudini. Altri aeroporti con un colore più rassicurante e meno appuntito.
Il giallo che si sentiva ora sulla pelle era infatti il pigmento dell’emarginazione e di quanti venivano ripudiati, fossero essi mendicanti o eretici, prostitute o traditori: come Giuda Iscariota.
Diede le dimissioni, e in meno di un quarto d’ora liberò il suo monolocale delle cose misere che in due anni vi aveva raccolto. Aprendo l’armadio rivide cinque camicie che senza saperlo aveva accantonato in un angolo, tutte con delle macchie di rosso.
Non era tomate. Non era pomodoro.
I francesi in questi casi dicono: rire jaune, ridere giallo, quando si reputa uno scherzo non divertente. Paolo Conte lo sa. Lui conosce i francesi. I francesi la sanno lunga.
Passo e chiudo.
§§§ in esclusiva per “Voci di hangar” §§§
# proprietà letteraria riservata #
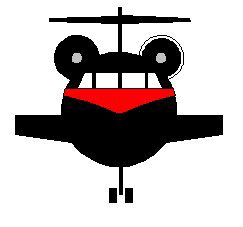 I francesi sono nostri cugini. E gli spagnoli sono nostri fratelli.
I primi sono antipatici e i secondi simpatici.
Ma è proprio vero?
I francesi sono nostri cugini. E gli spagnoli sono nostri fratelli.
I primi sono antipatici e i secondi simpatici.
Ma è proprio vero?
